–Le “Canzoni piemontesi” di p. Ignazio Isler (1)

Nel contesto della letteratura piemontese si può dire che padre Ignazio Isler sia un autore conosciuto a livello sia colto sia popolare: chiunque si ritenga appena interessato alla nostra storia letteraria, anche chi non ha mai sentito nominare Allione, o Calvo, conosce qualche verso (magari storpiato) del “Testamento d’un bevitore detto Giaco Tross”.
Credo che sia proprio questo il motivo per cui si sono accumulate sulla scrivania di Dario Pasero tante claudicanti edizioni in cerca di un curatore degno di tale nome. Padre Ignazio Isler era già entrato nella cultura popolare da vivo e, come tutta la tradizione popolare, è stato preso, ripreso, rivoltato, censurato, corretto, ampliato e ridotto. Le sue canzoni hanno spesso seguito la sorte di quelle composizioni che, nate in un’alt(r)a concezione della lingua piemontese, sono finite in banalità (basti pensare alla marziale “Lionòta”, svilita nella “Violeta” ).
Isler diventò parte integrante del repertorio popolare già nella sua maturità grazie all’uso che seppe fare della lingua parlata e dell’incredibile capacità di entrare nel tema sociale o di costume senza mai condire con il tartufo del didascalico. Padre Isler seppe usare in tutta la sua opera i gros mots dei suoi parrocchiani della Crocetta (e non solo…) tanto da far impallidire il medico di corte e cultore di piemontese Maurizio Pipino, cui dobbiamo sia la prima raccolta sia la prima manomissione. Sempre in virtù del suo linguaggio schietto e senza circonlocuzioni la sua (s)fortuna editoriale continuò per tutto l’800, ma fu altresì motivo di condanna allo scempio sistematico di ogni suo verso.
Anche l’edizione voluta da Andrea Viglongo e curata da Luigi Olivero (2), se raccoglie in un bel volume i testi pervenuti, ne presenta lezioni a dir poco discutibili e troppo personali, come evidenziato a suo tempo, e non senza polemiche, da Gianrenzo P. Clivio (3).
Ritengo tuttavia che la pirotecnica capacità comunicativa di Isler non sia stata quasi mai recepita al di là delle frequenti licenze scatologiche nel toccare temi su cui in genere si tace, senza coglierne le valenze che ce lo possono riproporre in altra veste.
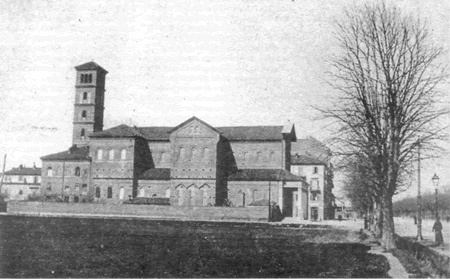
Isler nacque nel 1699, come da ricerche di Carlo A.M. Burdet, e morì nel 1778: traversò dunque quasi tutto il secolo dei Lumi, a cui, molto probabilmente, fu avverso come la maggior parte del clero subalpino (“ Ch’età malandrin-a,/ Che sécol vissios,/ Che gent libertin-a,/ Che mond licensios,/ L’é mai ogidì!”, Canzone 36); non penso proprio ci si debba aspettare una rivelazione alla Jean Meslier, il prete che dissimulò il suo ateismo materialista per decenni nella sua chiesetta d’Etrepigny nelle Ardenne. Credo però vi siano, nei suoi petardi poetico-musicali, tracce ancora da sondare di una cultura religiosa (e non solo) che affonda le sue radici in ben altro terreno che non sia quello delle osterie di fuori porta (la Crocetta era già fuori cinta).
I personaggi dell’Isler, così paradossali, così rabelaisiani, possono farci pensare ad un pessimismo antropologico di matrice religiosa (Agostino, Pascal) o meno (Hobbes), ma possono anche ricordarci che l’atteggiamento cinico-stoico nei confronti del corpo passò in qualche misura nell’ascetismo cristiano e nel monachesimo in generale: basti leggere pochi pensieri di Seneca o di Epitteto o di Marco Aurelio per averne un’idea, per trovare le immagini del corpo come “otre che ti racchiude”, tenuto in vita da “putrido sangue” (Marco Aurelio, I Ricordi, III.3), premesse per quell’iconografia della “morte trionfante” diffusa in tutta Europa dal Medioevo sino all’età barocca.
Lo stesso dicasi per l’atteggiamento nei confronti della donna e del corpo femminile, colto nella sua decadenza, nella sua caducità, nella contingenza della sua attrattiva; un attento lettore può trovare echi che passano per i rimpianti della bella Elmiera di Villon (Le Testament) che guarda sgomenta le sue nudità:
Quant me regarde toute nue,
Et je me voy si tres changiee,
Povre, seiche, megre, menu (LI)
….Quant des cuisses
Cuisses ne sont plus, mais cuissetes
Grivelees comme saulcisses (LV)
e tornano ad ammonire, o forse a deridere, la pochezza dell’uomo in balia alla sua libido:
…A scracia ch’a fà por,
L’ha dódes fontanele;
Sté a vëdde ch’a-j va ancor
Surtì le buele;
A l’ha l’odor ‘d punas,
E a venta sempre steje
Lontan sinch o ses ras,
S’un veul parleje.
A l’ha un difet maunat,
Ch’a l’é sigur ch’aneuja,
A tira ‘d rut e ‘d pat
Com una treuja.
E peui për compiment
Venta sovens netiela,
Ch’a l’ha continuament
la cagarela.
(Canzone 2)
È la miseria dell’essere umano che si crogiola nella sua bassezza (“Ordure amons, ordure nous assuit”, Villon, Le Testament, Ballade de la Grosse Margot), che danza inconsapevole una Totentanz sull’aria di una corenta scandita da innominabili strumenti a fiato:
…
Son virasse ‘l tafanari,
L’han fàit nen che pëtessé
(Canzone 6)
Vi sono tuttavia, al di là dei grandi temi filosofico-esistenziali, molti altri spunti di interesse nella (ri)lettura di Isler.
Un linguista potrebbe illustrare la varietà di torinese plebeo che il Nostro documenta, dal lessico, incredibilmente ricco, alla fonetica (p. es. caussat e non causset, crad e non cred, futuro in -ai e non in -eu), spiegare come le mutazioni linguistiche della Restaurazione (tra cui la perdita del passato remoto, in Isler ben vivo) contribuirono a spingere verso irrispettose riedizioni. … E sarebbe già, questo, un bel lavoro da svolgere.

L’edizione critica di Dario Pasero giunge a risolvere (e non con un semplice papin) un caso letterario da molti ritenuto insanabile, o almeno azzardato come ricomporre le viscere di un ferito straziato da una raffica di mitraglia, situazione in cui si trovava l’opera dell’Isler prima. Pasero, sia detto chiaramente, non ha solo alle spalle un curriculum filologico, ma altresì una lunga serie di prove letterarie ed editoriali che dicono quale sia la sua acribia.
Abbiamo dunque ora l’occasione, sfogliando l’edizione critica di Pasero, di conoscere le varianti, puntualmente riportate, dei manoscritti giacenti presso l’Accademia delle Scienze di Torino (fondo Armando ed altri), la Biblioteca Apostolica Vaticana di Roma (fondo Patetta), nonché delle edizioni che vanno dal 1783 (Pipino) al 1894, senza tralasciare i fogli volanti giunti sino a noi. Tutti i testi sono presentati in grafia normalizzata ma “Sopra il paese della Cocagna” mantiene anche quella di due manoscritti torinesi e di due romani al fine di permettere un’idea delle soluzioni grafiche adottate in più di due secoli.
I testi sono puntualmente tradotti, optando per una versione “discretamente libera”, lasciando in forma letterale le espressioni idiomatiche seguite, in parentesi, dalla forma italiana più comune.
Credo che l’auspicio dei compianti proff. Massano e Clivio, di portare al pubblico piemontese (e non solo agli studiosi) un’edizione critica di Isler sia diventato, grazie a Dario Pasero, una bella e utile realtà.
![]()
(1) Ignazio Isler, “Canzoni piemontesi”, a cura di Dario Pasero; Associazione Culturale “I Luoghi e la Storia”, Ivrea, 2013, pagg.454
(2) P. Ignazio Isler, “Tutte le canzoni e poesie pienontesi”, Viglongo, Torino, 1968
(3) Luigi Olivero, “Pseudocritica beat su Padre Ignazio Isler”, Il Cavour, n. 4, 1968: Gianrenzo P. Clivio, “Poesie d’Isler”, in Musicalbrandé , n. 37, marzo 1968
► «Sah, sah, chi ciama l’amolàire…»
► «Alessandria, che glòria! Vòstër fòrt ha avù vitòria…»
► Document divers
